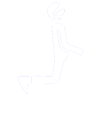Quando la leggerezza sfida la forza. Ne Il peso della farfalla, pubblicato da Feltrinelli nel 2009, Erri De Luca consegna ai lettori un racconto breve ma denso, poetico, quasi rarefatto, in cui si scontrano – e si fondono – la natura e l’uomo, la solitudine e la forza, l’istinto e la coscienza. Un’opera che, pur nella sua essenzialità, riesce a interrogare profondamente chi legge, suscitando riflessioni che durano ben oltre l’ultima pagina.
Il racconto ruota attorno a due figure principali: un vecchio cacciatore solitario, ormai prossimo alla fine dei suoi giorni, e un re dei camosci, un esemplare leggendario che domina da anni le cime delle montagne. Entrambi hanno raggiunto il culmine della loro esistenza: il primo come maestro nella caccia, il secondo come leader indiscusso del branco.
La loro storia si incrocia in un confronto finale, quasi epico, ma depurato da ogni teatralità. Non c’è eroismo spettacolare, solo il passo lento del tempo e l’avvicinarsi inesorabile della fine. L’uno è il riflesso dell’altro: entrambi anziani, solitari, entrambi portatori di una dignità antica. In questo loro incontro – o scontro – non si celebra la vittoria, bensì l’incontro tra due esseri che hanno abitato lo stesso mondo con forza, istinto e rispetto.
Il titolo del libro è rivelatore e insieme enigmatico: Il peso della farfalla. Un’immagine che rimanda alla leggerezza, all’impercettibile, ma anche alla forza simbolica delle piccole cose. È proprio il gesto minimo, il dettaglio quasi invisibile, a cambiare il destino. La farfalla, posandosi sul corno del camoscio, rompe un equilibrio che sembrava assoluto. Una scena che richiama il “battito d’ali” della teoria del caos, ma che in De Luca assume un valore esistenziale: nella fragilità risiede una forma di potenza.
La montagna, in De Luca, non è mai solo un paesaggio: è un luogo spirituale, un altare naturale dove si celebra il rito della vita e della morte. È spazio di solitudine e al tempo stesso di comunione profonda con il vivente. Il cacciatore, che non ha nome, è quasi un eremita: non caccia per sport né per guadagno, ma per affermare un’antica connessione con la natura, fatta di regole non scritte, di attese pazienti, di rispetto.
Nella scrittura di De Luca, la montagna diventa personaggio essa stessa. Le sue nevi, i suoi silenzi, i suoi animali non sono sfondo ma interlocutori. È su quelle cime che il tempo sembra dilatarsi, che il linguaggio dell’uomo si fa essenziale, ridotto all’osso, proprio come la scrittura dell’autore.
Lo stile di De Luca è asciutto, misurato, ma carico di poesia. Ogni frase è cesellata con precisione. L’autore, da sempre vicino alla lingua biblica, alla parola sacra, scrive come se ogni termine dovesse durare nel tempo. La prosa si avvicina alla poesia senza mai esserlo apertamente, e il risultato è una narrazione sospesa, eterea, ma mai vaga.
Le frasi brevi, i periodi concisi, le pause meditate contribuiscono a creare un ritmo che richiama il respiro lento della montagna, l’attesa del cacciatore, il passo sicuro del camoscio. La parola è usata con pudore, quasi con reverenza. Non c’è spazio per il superfluo, e proprio per questo ogni frase acquista un peso specifico.
Uno degli aspetti più affascinanti del racconto è il modo in cui De Luca costruisce il parallelismo tra uomo e animale. Il re dei camosci non è semplicemente una preda: è una creatura con una propria regalità, una coscienza istintiva, un codice morale non inferiore a quello umano. Il cacciatore, dal canto suo, riconosce e onora questa maestà. È come se il loro scontro fosse, in realtà, un abbraccio: il culmine di una lunga danza silenziosa che ha richiesto anni per compiersi.
Questo dualismo, questa specularità tra i due protagonisti, richiama una delle tematiche più care a De Luca: la profonda continuità tra essere umano e mondo naturale. La caccia, in questo contesto, non è brutalità ma rito, non è dominio ma riconoscimento. È l’incontro tra due solitudini che si annusano, si sfidano, si rispettano.
Il peso della farfalla è anche un libro sulla fine. Non solo la morte fisica, ma il tramonto di un’epoca, di un ruolo, di una funzione. Il vecchio cacciatore sa che non avrà più altre cacce. Il camoscio sa che il suo regno sta per concludersi. Eppure, non c’è disperazione in questa consapevolezza, ma piuttosto un senso di compiutezza, come se la vita avesse seguito un disegno preciso e, ora, si potesse lasciare andare.
La vecchiaia viene descritta senza indulgenza ma con grande dignità. È il tempo della resa dei conti, della memoria che si fa più nitida, delle scelte che non possono più essere rimandate. In questo senso, il libro è anche un omaggio alla forza della fragilità, al coraggio di affrontare il declino senza clamore.
In poco più di 60 pagine, Erri De Luca costruisce un’opera intensa, capace di parlare direttamente al cuore del lettore. Il peso della farfalla è un racconto che va letto con lentezza, lasciando che ogni parola trovi il suo spazio. È una riflessione profonda sull’esistenza, sulla natura, sull’onore, sull’inevitabilità della fine. Ma è anche, e forse soprattutto, un inno alla bellezza discreta delle cose piccole, di quei dettagli – come una farfalla – che cambiano tutto senza fare rumore.
Per chi ama la letteratura che si nutre di silenzi, di domande, di sguardi profondi, questo piccolo libro è un compagno perfetto. Un’opera che dimostra, ancora una volta, come la scrittura di Erri De Luca riesca a toccare il sacro con la leggerezza di un soffio.